 SESSUOLOGIA
SESSUOLOGIA
ORGASMO
FEMMINILE
ORGASMO
VAGINALE,
ORGASMO
CLITORIDEO
Purtroppo
molte donne
hanno problemi
connessi
all'orgasmo: da
una recente
inchiesta
condotta in
Italia dalla
Societa'
Italiana di
Medicina
Generale (SIMG)
con 600
questionari
distribuiti
negli ambulatori
di medici di
base, emerge
che il 30,1%
lamenta problemi
di orgasmo e il
26,9% di
lubrificazione.
Orgasmo
femminile
L’orgasmo è una
piacevole
risposta
psicologica e
fisiologica ad
un stimolo
sessuale. E’ il
terzo stadio,
dopo la fase di
plateau nel
rapporto
sessuale, a
cui normalmente
segue una fase
di rilassamento
della tensione
sessuale.
Durante
l'orgasmo, sia
nei maschi che
nelle femmine,
si verificano
contrazioni
muscolari
dell’ano e dei
muscoli pelvici,
così come degli
organi sessuali.
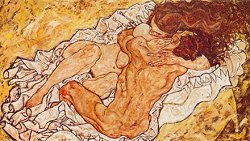 |
|
Egon
Schiele,
"Gli
amanti",
1917. |
Nella femmina,
l’orgasmo è
preceduto da una
lubrificazione
delle pareti
vaginali e da
una dilatazione
del clitoride
dovuta ad un
aumento del
flusso sanguigno
che rimane nel
tessuto spugnoso
che lo compone.
Alcune donne
manifestano un
arrossamento
diffuso della
pelle dovuto ad
una aumento del
flusso
sanguigno. Ma
mano che la
donna si
avvicina
all’orgasmo, il
clitoride si
muove verso
l’interno e le
piccole labbra
assumono una
colorazione più
scura. Quando
l’orgasmo
diviene
imminente, la
vagina
diminuisce di
dimensioni di
circa il 30% e
viene irrorata
di sangue e il
clitoride si
ritira sotto il
cappuccio
protettivo e
riemerge solo
quando la
stimolazione ha
termine. Durante
l’orgasmo
l’utero, la
vagina e i
muscoli pelvici
hanno una serie
di contrazioni
ritmiche. Dopo
che l’orgasmo è
finito, il
clitoride
riemerge e
recupera, in
circa 10 minuti,
le proprie
normali
dimensioni. A
differenza
dell’uomo, la
donna non ha un
periodo
refrattario e
perciò può avere
un secondo
orgasmo subito
dopo il primo
(alcune donne
possono averne 3
o 4): ciò è noto
come orgasmo
multiplo. Studi
mostrano che
circa il 13%
delle donne
hanno avuto
esperienze di
orgasmi
multipli.
L’orgasmo per la
donna, come per
l’uomo, può
essere associato
ad azioni
involontarie,
vocalizzazioni o
spasmi muscolari
in altre parti
del corpo.
Generalmente è
associato con
una generale
sensazione di
euforia.
"Eiaculazione"
femminile
Molte
donne durante
l’orgasmo
espellono del
fluido.
L’origine di
tale fluido sono
le ghiandole di
Skene
localizzate attorno
al meato
uretrale. Queste
ghiandole hanno
le dimensioni di
una capocchia di
spillo e possono
variare da
soggetto a
soggetto ed
anche non essere
presenti. Questo
spiega l'assenza
di questo
fenomeno in
alcune donne.
Perché si
verifica
l’orgasmo
In termini
evolutivi è
chiaro che
l’orgasmo
maschile è
necessario per
la riproduzione
in quanto
associato
all’eiaculazione.
Per l’orgasmo
femminile le
teorie
Darwiniane sono
meno dirette:
alcuni autori
sostengono che
contribuisca
alla ritenzione
dello sperma
all’interno,
aumentando le
possibilità di
fecondazione.In
termini
evolutivi è
chiaro che
l’orgasmo
maschile è
necessario per
la riproduzione
in quanto
associato
all’eiaculazione.
Per l’orgasmo
femminile le
teorie
Darwiniane sono
meno dirette:
alcuni autori
sostengono che
contribuisca
alla ritenzione
dello sperma
all’interno,
aumentando le
possibilità di
fecondazione.
Orgasmo vaginale
e clitorideo
Bisogna
premettere che
non ci sono due
differenti tipi
di orgasmo, può
cambiare
soltanto il tipo
di stimolazione
per
raggiungerlo. Il
clitoride è
molto sensibile
alle
stimolazioni.
Può essere
stimolato in
vari modi, con
stimoli manuali
o attraverso una
pressione e
sfregamento con
il corpo del
partner. Alcune
donne provano
dolore in
presenza di
stimolazione
diretta. Una
migliore
stimolazione si
ha con la donna
sopra in
posizione tale
che il clitoride
si sfreghi con
l’osso pubico
dell’uomo.
Questo peraltro
si verifica
anche quando è
l’uomo a stare
sopra in una
posizione tale
che l’osso
pubico eserciti
pressione nella
zona clitoridea.
Per alcune donne
la parte esterna
della vagina è
anche molto
sensibile.
Questo viene
riferito come
"orgasmo
vaginale".
In termini
evolutivi è
chiaro che
l’orgasmo
maschile è
necessario per
la riproduzione
in quanto
associato
all’eiaculazione.
Per l’orgasmo
femminile le
teorie
Darwiniane sono
meno dirette:
alcuni autori
sostengono che
contribuisca
alla ritenzione
dello sperma
all’interno,
aumentando le
possibilità di
fecondazione.
Sigmund
Freud sosteneva
che le donne
"mature" hanno
un orgasmo solo
vaginale, questo
ovviamente
conferiva un
ruolo centrale
al pene per la
soddisfazione
sessuale della
donna. In realtà
l’orgasmo è
un’esperienza
individuale e
non c’è un
percorso
"corretto" per
raggiungerlo.
Orgasmo e
barriere
psicologiche
Sebbene
l’utilizzo di
tecniche o
posizioni
particolari
possa essere
utile a favorire
l’orgasmo
femminile, anche
la mente della
femmina deve
essere
preparata. Per
molte donne
infatti sensi di
colpa,
insicurezza e
pensieri
negativi
inculcati
possono
prevenire la
comparsa di
un’eccitazione
adeguata e
dell’orgasmo.
Alcune donne
provano vergogna
nel sesso e non
riescono a
viverlo come
esperienza di
gioia. Alcune
donne si sentono
insicure del
proprio corpo,
lo sentono
lontano dai
"modelli di
bellezza" e ciò
provoca
difficoltà nel
raggiungere
l’orgasmo. Altre
donne sono così
concentrate su
se stesse per
raggiungere
l’orgasmo che
trascurano il
partner e
entrano in
ansia,
allontanandosi
dallo stato
psicologico
giusto premessa
essenziale per
l’effettivo
raggiungimento
dell’orgasmo.
Alcune donne
non hanno mai
provato
l’orgasmo e si
domandano se c’è
speranza di
provarlo.
Si, c'è.
Liberarsi
delle barriere
psicologiche, se
presenti, è il
primo passo. Poi
è importante
trovare modi per
entrare in
sintonia con il
proprio corpo,
per sentirsi a
proprio agio con
esso, per
"piacersi".
Infine bisogna
trovare il modo
di comunicare al
proprio partner
cosa piace,
quali
stimolazioni,
sia prima del
rapporto che
durante, possono
essere più
efficaci e quali
posizioni sono
preferite. Si
può sperimentare
la posizione lei
sopra, almeno
quando si
ritiene che
l’orgasmo si
avvicini,
cercando con dei
movimenti di
raggiungere
pressione e
sfregamento tra
la zona
clitoridea e
l’osso pelvico
del maschio.
Anche
l’atmosfera nel
rapporto è molto
importante; la
situazione, la
preparazione, il
luogo, le luci
(magari a lume
di candela)
possono giocare
un ruolo.
Esercizi
preparatori
Si
riporta, senza
in alcun modo
garantirne la
validità
scientifica, il
metodo Kegel.
Consiste nel
contrarre
i muscoli
pubococcigei
(come se si
cercasse di
trattenersi
dall’urinare)
con un
intervallo di 10
secondi per 150
volte ogni
giorno, con
contrazioni
rapide e lunghe.
RELAZIONE DI
COPPIA E
SESSUALITÀ
Il sesso è
ingrediente
fondamentale in
ogni relazione
di coppia.
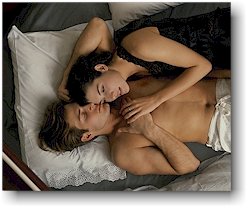 Può essere il
buon segnale
dell’intimità
che vige tra i
partner. In
questo caso i
sentimenti di
amore ed il
desiderio vanno
di pari passo
dando un grande
contributo
all’armonia
della relazione.
Non è sempre al
servizio di una
vicenda
qualitativa.
Può essere il
buon segnale
dell’intimità
che vige tra i
partner. In
questo caso i
sentimenti di
amore ed il
desiderio vanno
di pari passo
dando un grande
contributo
all’armonia
della relazione.
Non è sempre al
servizio di una
vicenda
qualitativa.
In molte
coppie il sesso
ha altre valenze
e ne risaltano
le sue funzioni
non
sessuali. C’è
chi gli
attribuisce la
funzione di
sonnifero. Chi
di sedativo. Chi
di
antidepressivo.
Chi, anche, di
momento di
rassicurazione e
di possesso. In
quest’ultimo
caso il sesso è
una mina vagante
che
difficilmente
porta ad
entrambi piacere
e quindi
sintonia.
Occorre
distinguere tra
sesso e
sessualità
Molte coppie,
infatti, fanno
sesso senza
riuscire ad
esprimere una
sessualità
piacevole.
Quest’ultima è
fatta di
ingredienti che
vanno ben oltre
il coito,
rispettando
tutti i suoi
momenti
preparatori: di
gioco, di
comunicazione,
di intimità. Tra
queste coppie vi
sono quelle
nelle quali il
sesso ha la
funzione di
sanatoria di
litigi aspri e
delle
conseguenti
tensioni. Vi
sono anche
quelle nelle
quali uno dei
due partner gli
attribuisce la
funzione di
essere una prova
dell’amore
dell’altro nei
suoi
confronti. Insomma,
malgrado il
sesso sia
necessario alla
vita di coppia,
non è
sufficiente
. Occorre che
gli sia dato il
dovuto spazio,
la dovuta
attenzione, la
dovuta cura,
perché sia
funzionale al
piacere e alla
felicità della
coppia. Di
fatto la
sessualità si
prepara fuori
dal letto, negli
atteggiamenti
della vita
quotidiana
. E’ molto
difficile che
essa sia un vero
terreno di
incontro quando
lo scontro,
l’ostilità, la
lotta per il
potere o per
affermare il
proprio ruolo
sono nel
repertorio
consueto dei
partner.
Evidentemente
ancor più
problematica è
la situazione in
cui tra i
partner non c’è
più sesso e, di
solito, neppure
intimità. Questo
distacco, che
nasce da un
disimpegno
emotivo e lo
alimenta,
porterà i due
attori sempre
più lontani uno
dall’altro anche
nelle cose della
vita quotidiana.
EIACULAZIONE
PRECOCE
Introduzione
Le
disfunzioni
sessuali
maschili legate
alla fase
dell’orgasmo
sono considerate
ad oggi molto
frequenti; dagli
ultimi convegni
internazionali
emerge infatti
un notevole
incremento delle
patologie
eiaculatorie e
una maggiore
attenzione degli
esperti in
materia alla
diagnosi e alla
terapia
risolutiva.
Dati recenti
riportano una
classificazione
precisa dei vari
disordini
dell’eiaculazione
con le
rispettive
percentuali
d’incidenza
nella
popolazione
italiana:
eiaculazione
precoce
(27.3%),
riduzione del
volume
dell’eiaculato
(27.6%)
eiaculazione
ritardata
(fino
all’anorgasmia)
4.4%. (Corona
et al.,
2005).
Classicamente
un disordine
come
l’eiaculazione
precoce è stato
considerato una
disfunzionalità
di tipo
psicologico,
solo
recentemente la
sessuologia
medica è
riuscita ad
individuare
anche eventuali
cause organiche,
quindi aprendo
l’orizzonte ad
una terapia più
di tipo
farmacologico
(Jannini et
al., 2007).
Cercare di
individuare una
responsabilità
fisiologica a
tutti i costi
per un sintomo
molto più in
linea con gli
stati emotivi,
ansiosi e
relazionali,
quindi
psicologici è
particolarmente
esagerato a
fronte alla
forte tendenza
degli ultimi
anni da parte
della categoria
dei medici di
risolvere le
disfunzionalità
sessuologiche in
generale,
essenzialmente
con l’ausilio
dei farmaci. Il
rischio a cui
siamo già
sottoposti è
sicuramente la
tendenza di un
forte
abuso.
La migliore
strada, come al
solito, si trova
solamente in una
via d’incontro,
quindi in una
maggiore e
migliore
integrazione
delle discipline
medico-psicologiche.
Prima di
addentrarci
nella
descrizione
della patologia
dell’eiaculazione
precoce e
affrontare le
possibili
risoluzioni
psicosessuologiche
e mediche è
necessario fare
un breve ma
fondamentale
inciso sulla
fisiologia del
processo
eiaculatorio.
È necessario
ricordare che i
disturbi
dell’orgasmo
maschile a
differenti
livelli sono
particolarmente
invalidanti,
portano
l’individuo che
ne soffre ad una
condizione di
forte
insicurezza,
disagio
relazionale,
abbassamento
della stima di
sé e in alcuni
casi più gravi
ad uno stato
depressivo.
Fisiologia del
processo
eiaculatorio
Cercando di
rendere più
semplice e
chiaro quello
che avviene
durante la fase
orgasmica
maschile e
considerando che
il processo
eiaculatorio è
il risultato di
una complessa
interazione
psiconeuroendocrina,
è utile
ricordare che
l’eiaculazione
consiste di due
fasi precise e
distinte: l’emissione
e l’eiaculazione
vera e propria.
L’orgasmo in sé
è il risultato
dell’elaborazione
cerebrale
(mentale) di
tutti quegli
stimoli
“sensitivi”
originati
direttamente sul
pene (nervo
pudendo),
amplificati
dalle forti
sensazioni
dovute alla
contrattilità
involontaria
della fase
eiaculatoria
stessa.
La fase di
emissione,
tenuta sotto il
controllo
volontario
dell’individuo,
è il risultato
di un
riflesso spinale
(sistema nervoso
simpatico) che
innesca una
serie di
contrazioni
sequenziali di
quegli organi
definiti
“sessuali
accessori”,
ovvero le
principali
strutture
contribuenti
alla formazione
del liquido
seminale
(vescicole
seminali,
prostata,
ghiandole
bulbo-uretrali e
testicoli).
Ricordiamo che
per attivare la
fase di
emissione sono
necessari
stimoli erotici
genitali
(tattili, orali)
e stimoli
erotici centrali
risultanti
dall’elaborazione
di immagini
visive, uditive,
olfattive,
fantasie,
ricordi). La
componente
visiva per gli
uomini è
particolarmente
importante. La
maggior parte
degli individui
di sesso
maschile,
rispetto a
quelli di sesso
femminile, è
particolarmente
attratta dalla
stimolazione di
tipo visivo e
tattile.
Anche la fase di
eiaculazione è
determinata da
un riflesso
spinale del
sistema nervoso
simpatico, ma a
discapito della
precedente ha un
limitato
controllo
volontario.
Infatti, nel
momento in cui
l’uomo
percepisce
l’inevitabilità
eiaculatoria
difficilmente
può rientrare in
uno stato di
eccitazione
iniziale,
precipita
direttamente nel
passaggio
definito anche
di non ritorno,
avviandosi alle
contrazioni
orgasmiche e
facendo
fuoriuscire
dall’orifizio
uretrale una
consistente
quantità di
“sperma”.
Responsabili
della
propulsione del
liquido seminale
in uretra sono i
muscoli
ischio-cavernoso
e
bulbo-cavernoso
(muscolatura del
pavimento
pelvico), mentre
le contrazioni
ritmiche
involontarie
dello sfintere
uretrale
esterno, agendo
come una pompa
suzione-eiezione,
aspirano lo
sperma
dall’uretra
posteriore in
fase di
rilassamento
espellendolo
vigorosamente
nell’uretra
bulbare in fase
di contrazione.
Durante la fase
di eiaculazione,
quindi
orgasmica, anche
lo sfintere
anale produce
delle
contrazioni
involontarie
determinando
intense
sensazioni di
piacere.
DISFUNZIONI
SESSUALI
Eiaculazione
Precoce
L’eiaculazione
precoce (EP)
rispetto ad
altre
disfunzionalità
sessuologiche
come ad esempio
la
disfunzione
erettile,
viene ancora
oggi
“autodiagnosticata”
dai soggetti che
presumibilmente
ne soffrono.
Questo rende non
facile la
possibilità di
creare criteri
utili e stabili
per individuare
i possibili
confini della
forma più
patologica.
Utilizzando la
definizione del
DSM IV TR
(Manuale
Diagnostico e
Statistico dei
Disturbi
Mentali) l’EP
viene definita
come “una
persistente o
ricorrente
eiaculazione a
seguito di una
minima
stimolazione
sessuale prima,
durante, o poco
dopo la
penetrazione e
prima che il
soggetto lo
desideri”.
Di recente
alcuni autori
hanno cercato di
classificare il
disagio dell’EP
associandolo
all’Intravaginal
Ejaculation
Latency Time
(IELT), ovvero
il lasso di
tempo che
intercorre fra
l’intromissione
in vagina e
l’eiaculazione
intravaginale
(Fratantonio,
et al.,
2007). La
classificazione
ottenuta
evidenzia un
grado
severo:
prima della
penetrazione o ≤
15 sec; un
grado
moderato:
≤ 1 minuto e un
grado
lieve:
≤ 2 minuti.
Considerando che
l’attività
penetrativa non
è
necessariamente
indirizzata al
solo rapporto
vaginale è utile
ricordare quanto
i tempi possano
essere variabili
e individuali a
prescindere
dalla stessa
disfunzione.
Il disagio
dell’EP è senza
dubbio molto più
comprensibile se
associato alla
forte e
irrefrenabile
sensazione di
perdita del
controllo
durante la fase
eccitatoria,
penetrativa o
meno, che è
contestualmente
responsabile di
un forte
distress
psicologico e
dei disagi nelle
relazioni
interpersonali.
Per una maggiore
chiarezza
diagnostica è
necessario
ricordare che
l’EP deve essere
osservata anche
in base all’epoca
d’insorgenza:
EP
primaria,
quando è
presente sin
dalle prime
esperienze
sessuali
(pubertà-adolescenza)
e non si è mai
modificata;
EP
secondaria,
quando compare
improvvisamente
dopo un periodo
che il soggetto
descrive
accettabile dal
punto di vista
del controllo
eiaculatorio. In
questi casi i
motivi
dell’improvvisa
disfunzione
eiaculatoria
sono solitamente
sconosciuti al
soggetto e
tendenzialmente
destrutturanti.
Ancora, è
necessario
comprendere il
momento
dell’insorgenza:
EP ante
portas,
quando il
sintomo si
manifesta ancor
prima della
penetrazione. Ci
sono uomini che
spesso, presi
dalla troppa
eccitazione, non
riescono neppure
a spogliarsi
completamente!
EP intra
moenia,
quando si
manifesta
esclusivamente
durante la
penetrazione.
Infine è
necessario
osservare anche
la frequenza
e l’occasione
d’insorgenza:
EP
assoluta,
il soggetto
manifesta il
sintomo sempre a
prescindere dal
partner
EP
relativa o
situazionale,
quando si
manifesta solo
con un
determinato
partner.
Dall’esperienza
clinica è facile
osservare
un’improvvisa
eiaculazione
precoce con la
partner abituale
(moglie,
fidanzata,
compagna) e una
non precocità
con eventuali
partner
occasionali
(amanti,
prostitute…).
Come già
accennato in
precedenza l’EP
è la più
frequente
patologia
sessuale
maschile, con
incidenza
superiore pari
al 20% della
popolazione
adulta, anche se
la maggior parte
delle
consultazioni
sessuologiche
avviene per la
disfunzione
erettile. A
volte molti
uomini che
richiedono una
consulenza
specialistica
sono convinti
che i loro
disagi siano
legati ad un
disturbo
dell’erezione,
oppure ad un
calo del
desiderio,
omettendo la
vera
responsabile:
l’EP,
solitamente
primaria, intra
moenia e
assoluta.
La distribuzione
dell’EP a
livello
geografico
appare omogenea
anche se in
alcuni paesi
sembra più
elevata rispetto
ad altri. Negli
Stati Uniti è
stata stimata
una prevalenza
intorno al 24%;
in Europa invece
è presente un
ampio range di
3,7-66%; in
Estremo Oriente
la stima è del
29,1% e nei
paesi medio
orientali e
africani invece
è del 17,3%
(Jannini, Lenzi,
2005; Laumann
et al,
1999;
Papaharitou,
2005).
Sicuri del fatto
che l’EP non può
essere
considerata una
“malattia”,
bensì un
particolare
sintomo
psicosomatico
che procura nel
soggetto disagi
e
disfunzionalità
psicologico-emotive
e relazionali, è
necessario
accennare le
possibili cause
o concause di
ordine
psicologico e
medico
responsabili
dell’evento
indesiderato.
Ancor prima è
utile rammentare
che ogni essere
umano di sesso
maschile è “in
potenza” un
eiaculatore
precoce, nel
senso che
fisiologicamente
il tempo utile
dal momento in
cui un uomo si
eccita al
momento in cui
raggiunge
l’orgasmo
(egoismo
sessuale
maschile) non è
strettamente
funzionale al
processo
anatomo-fisiologico
della risposta
sessuale! Il
fatto di
prolungare la
sensazione di
piacere
(preorgasmica),
ovvero di
rimanere in
linea con i
tempi orgasmici
femminili
(differenti e
molto più
prolungati)
sviluppano
necessari
cambiamenti di
controllo
eiaculatorio
socialmente
condivisibili.
Un uomo allora
non “deve” dare
sfogo al suo
istintuale
piacere
sessuale, ma
conformarsi con
la società di
appartenenza.
L’EP ha sempre
fatto parte
dell’essere
umano.
Storicamente ha
cambiato
dimensione ed è
risultata
disfunzionale
compromettendo
il buon (anche
se egoistico)
principio del
piacere
maschile.
Un piccolo
aneddoto: molto
probabilmente
50-60 anni fa i
nostri avi,
vivevano
l’esperienza
erotico sessuale
con una certa
precocità, ma
questo non
sembrava
preoccuparli più
di tanto: non
percepivano la
rapida
conclusione del
rapporto come
disfunzionale.
Le donne di quel
periodo storico
vivevano però
una situazione
alquanto chiusa
e succube della
loro sessualità:
ignoravano in
maggioranza il
piacere
orgasmico, non
si conoscevano a
livello corporeo
e la sessualità
veniva vissuta
come un
“piacere” da
dare al proprio
compagno e
solitamente
finalizzata alle
gravidanze.
Solamente dopo
il “femminismo”
e la rivoluzione
sessuale degli
anni 60-70 si è
osservato un
forte
cambiamento
della sessualità
e soprattutto
del piacere
femminile
(ritrovato).
Questo ha fatto
fare un balzo in
avanti rispetto
alla
liberalizzazione
sessuale, alla
parità dei
diritti, ma
forse molti
uomini non sono
riusciti ad
adeguarsi, sono
rimasti
incastrati in
quelle “regole
interne” che a
parer loro
sembravano,
potremo dire
sembrano, del
tutto naturali!
Quando l’EP
viene
diagnosticata su
base psicologica
possono incidere
le seguenti
cause in
riferimento a
differenti
approcci
psicoterapeutici:
interpretazioni
psicodinamiche:
a) eccessiva
masturbazione
durante
l’adolescenza
(eccessivo
narcisismo)
senza apprendere
il possibile
controllo delle
sensazioni
preorgasmiche;
b)
ira/aggressività
repressa
(misoginia
inconscia/sadismo
del “furto
dell’orgasmo
femminile”)
fattori
comportamentali:
a) prime
esperienze
sessuali
traumatiche;
b) apprendimento
di adattamento
(condizionamento
di raggiungere
l’orgasmo in
breve tempo per
paura di essere
scoperto)
fattori
cognitivi:
a) ansia da
prestazione
(stato ansioso
superficiale
legato al
desiderio di
dimostrare la
propria
potenzialità
sessuale;
mancato utilizzo
di metodi
contraccettivi;
paura dei
fallimenti) che
attraverso
un’ipereccitazione
determinerebbe
una riduzione
del controllo
delle sensazioni
pre-eiaculatorie;
b) senso di
colpa (attività
sessuale
prematrimoniale,
attività
sessuale extra
coniugale);
c) paura
(gravidanza non
programmata,
timore di
malattie
trasmesse
sessualmente).
Quando l’EP
viene
diagnosticata su
base organica si
osservano le
seguenti teorie
biologiche e
cause organiche
responsabili: a)
alterati
meccanismi
ormonali
(ipotestosteronemia);
b) alterazioni
riflessogene
(disturbi
muscolo-tensivi
a carico del
pavimento
pelvico;
c) alterazioni
neurologiche;
d) alterazioni
vascolari.
Malattie
endocrine:
a) ipogonadismi
e/o
ipotiroidismi.
Malattie
Urologiche:
a) prostatiti;
b) fimosi;
c) frenulo corto
del prepuzio.
Cause
Iatrogene:
Amfetamine.
Cause
Voluttuarie:
assunzione di
droghe
(cocaina).
La
terapia
Come già
premesso
nell’introduzione
il migliore
approccio
terapeutico alla
disfunzione
dell’eiaculazione
precoce deve
integrare
perfettamente la
componente
psicologica e
quella
medico-farmacologica.
Ecco la
necessità,
quindi di un
inquadramento
diagnostico il
più possibile
preciso, che
evita di
indirizzare il
paziente in
percorsi confusi
e poco
produttivi.
Spesso il
paziente che
arriva dallo
psicosessuologo
ha già “provato”
troppi
trattamenti
terapeutici, a
volte solo
psicologici, ma
nella maggior
parte dei casi
solo
medico-farmacologici.
Questo porta il
soggetto ad un
forte
abbassamento
della propria
stima di sé e ad
una motivazione
per la
risoluzione del
sintomo di tipo
“magico”.
Se la diagnosi
iniziale è
esclusivamente
di tipo organico
sarà necessario
indirizzare il
soggetto verso i
seguenti
trattamenti:
- terapia
antibiotica
mirata (nel
caso di
prostatiti e
infezioni delle
ghiandole
accessorie
maschili);
- farmaci
antinfiammatori
(nel caso
in cui le
infezioni delle
ghiandole
accessorie
maschili siano
di tipo
cronico);
- metimazolo
e/o
β-bloccanti
(ipertiroidismi);
- terapia
ormonale
sostitutiva
(nelle forme di
ipoganadismo);
-
trattamento
chirurgico
(fimosi e
frenulo corto).
Nel caso invece
la diagnosi sia
di tipo
psicologico è
necessario
intervenire con
un approccio
psicosessuologico
integrato.
Nella terapia
psicosessuale è
importante
lavorare insieme
al partner
(quando
presente),
oppure scegliere
un intervento
mirato alla
riformulazione
della percezione
ed educazione
del sé corporeo
con il singolo.
Alcune delle
tecniche
comportamentali
utilizzate nella
terapia
psicosessuale
sono: la tecnica
dello
squeeze pausa
(compressione),
che consiste
nell’esercitare
una leggera
compressione sul
glande (3-4
secondi) quando
il pene è in
erezione e
immediatamente
prima
dell’eiaculazione.
La tecnica dello
Stop-Start
che consiste nel
fermarsi e
ritrarre il pene
durante il
rapporto
sessuale quando
l’uomo sente di
essere prossimo
all’eiaculazione
e quindi non più
in grado di
controllare il
riflesso
eiaculatorio.
Gli
Esercizi di
Kegel
che si basano su
un progressivo
controllo da
parte dell’uomo
dei muscoli
pubo-coccigei
della zona del
pavimento
pelvico.
Queste tecniche
sono solamente
una piccola
parte
dell’approccio
psicosessuale
integrato.
L’approccio
prevede una vera
e propria
rieducazione
alla corporeità
e al piacere
sessuale, nonché
il migliorare le
proprie modalità
relazionali
abbattendo falsi
miti e sciocchi
tabù sessuali.
Conclusioni
L’importanza di
una diagnostica
accurata, ovvero
di linee guida
precise in tema
dell’inquadramento
diagnostico
dell’Eiaculazione
Precoce, come
rimarcato anche
in un recente
articolo
scientifico
americano di
Sharlip (2006),
sono alla base
del successo
terapeutico del
sintomo
sessuologico e
della miglioria
della qualità
della vita degli
stessi soggetti
affetti da
sintomo stesso.
Le ricerche
prevalentemente
di ordine medico
hanno messo in
evidenza una
buona risposta
risolutiva
associata
all’utilizzo di
alcuni farmaci,
anche se non
sono pochi gli
effetti
collaterali
evidenziati.
Inoltre, sembra
che nessuno di
questi farmaci
possa assicurare
una persistenza
dei risultati
ottenuti dopo la
sospensione del
trattamento (La
Vignera et
al, 2007).
Per quanto
riguarda invece
le terapie
psicosessuologiche,
da molto tempo
diffuse, sono
purtroppo
carenti dal
punto di vista
dei dati
scientifici.
Infatti, non vi
sono studi
precisi sulla
reale efficacia
a fine
trattamento.
La
sperimentazione
in corso con
farmaci
antidepressivi a
lungo termine e
una maggiore e
migliore
scientificità
apportata dagli
studi di
carattere
psicosessuologico
potranno
garantire una
migliore
comprensione
della
risoluzione del
sintomo
Eiaculazione
Precoce in una
visione
neuro-psico-endocrinologico
e sociale
integrata.
Sarebbe
decisamente
incomprensibile
scindere psiche
e corpo in una
risposta di
“vitale”
importanza come
quella dell’orgasmo.
EIACULAZIONE
RITARDATA
Sono
variamente
distribuite tra
organiche e
psicogene.
L’eiaculazione
ritardata non
rappresenta, di
per sé,
un’entità
patologica.
Nella cultura
orientale è
addirittura una
pratica che
attinge le sue
radici in
fondamenti
filosofici. Il
cosiddetto
“coito
riservato”
infatti è una
pratica che,
secondo la
filosofia Zen,
fa sì che il
maschio continui
a fare l’amore
senza mai
eiaculare anche
per molte ore,
con lo scopo di
attingere
energia dalla
donna e di non
disperdere la
propria. Nella
nostra cultura
ciò di solito
non avviene e
l’eiaculazione
ritardata si può
presentare
soprattutto in
condizioni di
scarso
eccitamento.
Tra le cause
organiche che la
inducono e che
inducono, ancor
più
precisamente,
l’eiaculazione
impossibile,
troviamo:
-
Cause
neurologiche
-
tumori o
traumi del
midollo
- sclerosi
multipla
- morbo di
Parkinson
- neuropatie
-
Cause
endocrino-metaboliche
-
ipotiroidismo
- diabete
-
Cause
chirurgiche
-
interventi
nel
distretto
addomino
- pelvico
- perineale
-
Farmaci
- bloccanti
alfa
-
adrenergici
-
neurolettici
-
antidepressivi
triciclici e
serotoninergici
- alcool
-
metoclopramide
-
cannabinoidi
- narcotici
- In
particolare
sono i
farmaci
antidepresivi
triciclici e
serotoninergici
che
presentano
come
frequente
effetto
collaterale
il ritardo
dell’eiaculazione.
-
DISTURBO DA DESIDERIO SESSUALE
IPOATTIVO E
AVVERSIONE
SESSUALE
-
Cause
della
patologia
del
desiderio
sessuale
ipoattivo
Il sociologo
Kinsey, già 50
anni orsono,
aveva dimostrato
che il
comportamento
sessuale (in
particolare
quello maschile)
si distribuisce
secondo una
curva ai cui due
estremi si
collocano da una
parte coloro che
hanno un
desiderio
sessuale basso
e, dall'altra,
quelli che lo
hanno molto
alto. Questi
ultimi possono
avere anche 30 o
più rapporti
sessuali la
settimana per
molti anni,
mentre gli altri
avranno una vita
sessuale molto
povera. Se ne
seguiamo una
lettura medica,
non si può dire
che l'uno e
l'altro
rientrino nella
patologia: sono
soltanto i due
estremi di un
fenomeno
biologico.
Anche se il
DSM-IV ci ha
mostrato
diagnosi
piuttosto
precise della
patologia del
desiderio
sessuale, non è
facile
stabilire, al di
fuori di
situazioni
eclatanti, quale
è il limite al
di fuori del
quale sta la
patologia.
Spesso si tratta
della percezione
soggettiva del
proprio o
dell'altrui
desiderio. In
questo entrano
in gioco fattori
individuali e di
coppia,
aspettative,
confronti con
esperienze
precedenti che
possono rendere
insoddisfacente
ciò che non
avrebbe
connotati di
patologia. Di
fatto, il
desiderio
sessuale sia
nell'uomo, sia
nella donna,
rappresenta un
patrimonio che
matura seguendo
precise tappe
biologiche e
psicologiche che
vedono dapprima
il bambino alla
scoperta del
proprio corpo e
quindi del
piacere. Si
organizzerà
ulteriormente
poi nella
maturazione
psicosomatica
che si avvia con
la pubertà e
troverà, nelle
prime relazioni
di coppia e nei
primi
accoppiamenti,
il terreno dove
poter esprimere
il grande o
piccolo
patrimonio
conseguito.
Tanto migliore
sarà stata
l'evoluzione
psicosessuale,
tanto migliore
sarà la
possibilità di
vivere e di
esprimere il
desiderio
Avversione
sessuale e
inibizione del
desiderio
L’avversione
sessuale
esprime sempre
marcate
difficoltà
emotive verso il
sesso in
condizioni
psicologiche e
psicopatologiche
che coinvolgono
estrema ansietà,
sentimenti di
terrore,
attacchi di
panico e
manifestazioni
somatiche
(nausea,
palpitazioni,
vertigini e
difficoltà alla
respirazione).
In alcuni casi
l’avversione è
estesa versa
tutti gli
stimoli a
valenza
sessuale,
compresi baci e
toccamenti.
Questa
eventualità è
associata
spesso, come
accade in
patologie come
l’anoressia
nervosa, a un
disturbo
dell’immagine
corporea (o
comunque a un
vissuto negativo
del proprio
corpo) e a una
cattiva
elaborazione
della propria
femminilità. Ne
possono essere
causa anche
esperienze
sessuali
traumatiche
vissute
nell’infanzia o
nell’adolescenza,
quali molestie o
abuso sessuale.
Le cause
psicologiche di
inibizione del
desiderio
sessuale sono
quindi molte:
individuali e di
coppia, come
pure rilevante è
la sua
dipendenza da
condizioni
psichiatriche
.
Oltre a
queste, vi sono
una moltitudine
di cause
organiche
che possono
portare a
riduzione o
scomparsa del
desiderio che si
possono
schematizzare
per aree:
-
Malattie
primitive,
maschili o
femminili,
delle gonadi
a origine
disgenetica,
infiammatoria,
degenerativa,
tumorale,
autoimmune,
ecc
-
sindrome di
Klinenfelter
- sindrome
di Turner
- sindrome
di
Reinfenstein
- anorchia
congenita
-
orchiectomia/ovariectomia
-
criptorchidismo
- necrosi
testicolare
da torsione
del funicolo
- leydigoma
- menopausa
-
Alterazioni
o patologie
ipotalamo-ipofisarie
a eziologia
infiammatoria,
degenerativa,
tumorale,
autoimmune
che
determinano
quadri di:
-
ipopituitarismo
globale
anteriore
- deficit
isolato di
gonadotropine
-
Cause
endocrine
maschili e
femminili
extra-gonadiche:
-
iperprolattinamia
- sindrome
di Cushing
- morbo di
Addison
- mixedema
- tumore
surrenalico
femminilizzante
- sindrome
da
carcinoide
- pinealoma
secernente
- sindromi
paraneoplastiche
-
Patologie
sistemiche:
- epatopatie
croniche
- nefropatie
croniche
- emopatie
- neoplasie
- malattie
defedanti in
genere
-
Diabete
mellito
-
Disturbi
neurologici:
-
morbo di
Parkinson
- epilessia
del lobo
temporale
- traumi
cranici
- neoplasie
del lobo
prefrontale
-
Farmaci:
-
estrogeni
(nell'uomo)
-
anti-androgeni
- reserpina
-
clorotiazide
-
spironolattone
- alfa e
betabloccanti
- metildopa
-
anticolinergici
-
antistaminici
-
antidepressivi
(in dosaggi
inopportuni
e con
indicazione
scorretta)
-
neurolettici
-
benzodiazepine
- sali di
litio
-
barbiturici
-
cannabinoidi
-
allucinigeni
- narcotici
In primo
luogo, va
evidenziata la
dipendenza del
desiderio
sessuale dagli
ormoni sessuali,
variabile da
soggetto a
soggetto, e che
possono
sussistere anche
per induzione
psicologica in
alcune
condizioni (la
più eclatante è
la
castrazione).
Una frequente
influenza sul
desiderio è data
dalle patologie
sistemiche per
effetto di
fattori
metabolici e
psicometabolici.
In soggetti
cirrotici,
malnutriti, con
insufficienza
renale o con
diabete mellito,
i processi
metabolici
rallentano e si
ripercuotono
prima sulle
funzioni
dell'organismo,
compresa quella
sessuale, e poi
sull'assetto
psicologico. Ne
è un esempio
paradigmatico il
diabete mellito,
la cui azione
negativa sul
desiderio è
secondaria alle
alterazioni
vascolo-nervose
indotte da tale
patologia.
Tra i
farmaci ,
particoare
attenzione va
data a quelli di
uso più comune,
come alcuni
antiipertensivi
e gli
anti-recettori
H2 per
l'istamina
qualche volta
ancora usati per
la terapia
dell'ulcera.
Infine alcuni
farmaci attivi
sul Sistema
Nervoso Centrale
(antidepressivi,
cannabinoidi,
narcotici), dopo
una prima fase
nella quale si
può osservare un
rilancio del
desiderio, fanno
seguire un calo
dell'attività
sessuale, con
compromissione
della libido.
Aumento del
desiderio
sessuale
Esistono
alcune patologie
psichiatriche
nelle quali
l'eccesso di
desiderio
sessuale ne
rappresenta uno
dei sintomi.In
particolare
negli episodi
maniacali, che
sono il
contraltare di
quelli
depressivi. In
questo disturbo
mentale lo stato
di eccitamento
invade molte
aree, attività e
comportamenti,
compreso quello
sessuale. Può
essere presente
anche in un
disturbo di
personalità,
come il
cosiddetto
"disturbo
borderline".Tra
le cause
principali, sul
piano organico
si possono
rilevare:
-
Disturbi
endocrini
-
ipertiroidismo
-
acromegalia
-
Farmaci
-
ormoni
sessuali
- L-dopa
- stimolanti
(stricnina)
-
paraclorofenilalanina
Tra i
disturbi
endocrini,
l'acromegalia è
nota da molto
tempo come una
condizione nella
quale la
pulsione
sessuale è
aumentata.
Cesare Lombroso
definiva gli
acromegalici
come "strenui
amatori" e
ricerche
successive hanno
evidenziato un
aumento della
libido in
soggetti con
questa
patologia.Tra i
farmaci, si deve
ricordare come
la L-dopa, usata
per la cura del
Morbo di
Parkuinson,
provochi un
aumento del
desiderio
sessuale.
A volte la
mancanza di
desiderio o
la sua
ipoattività
dipendono da
inibizioni
psicologiche
transitorie: un
periodo di
stress
particolarmente
intenso, impegni
di lavoro più
pressanti del
solito,
preoccupazioni
per la salute di
un genitore, un
periodo di
tensione nel
rapporto di
coppia per un
dato problema e
tutta la miriade
di seccature
quotidiane che,
quando si
accentuano,
possono
interferire con
il desiderio. Di
solito, in
questi casi, non
si arriva a
vedere
organizzato un
quadro clinico;
la diminuzione
del desiderio
sessuale non
proseguirà,
solitamente,
troppo oltre il
mantenersi della
causa che l'ha
scatenata, salvo
complicazioni.
Infatti, se
nella coppia vi
è uno stato di
tensione
latente, di
condizioni nelle
quali si annida
la lotta aspra
per il potere,
la necessità di
reclamare il
proprio ruolo e
se la
comunicazione
già difetta,
vicende queste
piuttosto
comuni, si
possono
innescare
reazioni a
catena che
contaminano più
pesantemente il
desiderio. Vi
sono anche
condizioni più
precisamente
psichiatriche
che impediscono
a questa energia
di esprimersi.
In primo luogo,
la
depressione
. Disturbo
diffuso, in
molte sue
gradazioni
sintomatologiche,
è il
responsabile del
ritiro di molti
desideri dalle
opzioni
dell'esistenza
di un dato
individuo. In
questa
condizione non
vi sarà il
desiderio di
fare l'amore, ma
neppure quello
di lavorare, di
godersi il tempo
libero, di
frequentare gli
amici. Non si
tratterà quindi
di un problema
strettamente
sessuale, ma la
sessualità sarà
una delle tante
aree di vita e
del
comportamento
inibite da
questa
psicopatologia. Diverso
è il quadro,
evidentemente,
se il disturbo
depressivo è
insorto in
seguito ad una
disfunzione
sessuale. Anche
in altri
disturbi mentali
il desiderio può
essere ridotto,
come nel
disturbo
ossessivo-compulsivo,
nell'ansia
generalizzata e,
non raramente,
in presenza di
psicosi.