 ECOGRAFIA
MAMMARIA
ECOGRAFIA
MAMMARIA
Il tumore
della
mammella
rappresenta
tuttora la
neoplasia di
più
frequente
riscontro in
ginecologia
e la causa
di morte in
Italia di
più di
10.000 donne
ogni anno,
circa 30
donne al
giorno.
Nell’ambito
della
diagnostica
senologica
che tenta di
combattere
tale
patologia,
l’ecografia
negli ultimi
anni sta
assumendo un
ruolo sempre
maggiore,
accanto alla
tradizionale
triade
diagnostica
esame
clinico-mammografia-
esame
citologico.
L’evoluzione
tecnologica
delle
apparecchiature
ecografiche
legata
principalmente
alla
utilizzazione
di sonde ad
elevata
frequenza e
ad una
sempre
maggiore
ottimizzazione
del potere
di
risoluzione,
ha infatti
permesso
all’ecografia
di passare
dall’iniziale
limitato
compito di
differenziazione
della natura
solido-liquido
del nodulo a
quella ben
più
importante
di una
approfondita
analisi dei
caratteri
morfo ed
ecostrutturali
del nodulo
che ha
consentito
alla
metodica fin
dagli inizi
degli anni
80, il
raggiungimento
di
un’accuratezza
diagnostica
per il
cancro della
mammella
valutata tra
il 78 ed il
96% (Huber
1982,
Kabayoschi
1982,
Sickles
1983, Murat
1984,
Dambrosio
1989).
L’esame
ecografico
della
mammella si
è inoltre
dimostrato
particolarmente
utile ed
affidabile
nello studio
delle
alterazioni
benigne
della
mammella
(malattia
fibrocistica,
fibroadenomi,
patologia
flogistica,
dilatazioni
dei dotti
galattofori)
in
particolare
qualora
dette
alterazioni
si
manifestino
in mammelle
mastosiche
ad alta
componente
ghiandolare
o in quadri
di seno
denso
giovanile.
La tecnica
ecografica
risulta
inoltre
attualmente
la tecnica
di scelta
per lo
studio della
mammella
operata, per
la guida al
prelievo
citologico
bioptico di
lesioni non
palpabili
ecograficamente
evidenziabili
e per il
posizionamento
preoperatorio
di repere
metallico su
noduli non
palpabili.
APPARECCHIATURE
E METODOLOGIA
DELL’ESAME
L’esame
ecografico
delle
mammelle
risulta
particolarmente
impegnativo
e
difficoltoso
per la
scarsa
differenza
di impedenza
acustica
presente tra
i tessuti
che
compongono
tale
ghiandola e
per la
necessità di
dover
rilevare
minimi e
sottili
dettagli
ecostrutturali
per la
identificazione
di eventuali
alterazioni
focali e
ancor più
per una
differenziazione
tra
patologie
benigne e
maligne.
Oltre ad
indispensabili
competenze
teoriche e
tecniche
dello
operatore è
pertanto
necessario
utilizzare
apparecchiature
ecografiche
in real-time
tecnologicamente
d’avanguardia
sia per
quanto
riguarda i
sistemi di
elaborazione
e di
rappresentazione
del segnale
che per
quanto
riguarda i
sistemi di
focalizzazione
del fascio
ultrasonico.
Essendo la
ghiandola
mammaria un
organo
superficiale,
per ottenere
una migliore
definizione
dell’immagine
ed un
incremento
del potere
di
risoluzione
della
apparecchiatura
risulta
indispensabile
la
utilizzazione
di
trasduttori
ad elevata
frequenza
potendosi
identificare
nei 7.5 MHz
la frequenza
di emissione
ottimale.
Per uno
studio più
dettagliato
di eventuali
alterazioni
focali può
essere
inoltre
considerata
la
utilizzazione
di sonde ad
elevata
frequenza
(10-13 MHz).
La sonda,
lineare o
convex, deve
presentare
una
lunghezza di
almeno 5 cm
al fine di
consentire
lo studio di
porzioni
sufficientemente
ampie delle
mammelle e
di escludere
il rischio
di una
mancata
esplorazione
di porzioni
ghiandolari
durante lo
spostamento
della sonda
sulla
superficie
della
mammella. La
utilizzazione
di sonde
dotate degli
attuali
sofisticati
sistemi di
focalizzazione
può
consentire
di eseguire
l’esame
anche senza
la
interposizione
di un
distanziatore
tra sonda e
superficie
cutanea. Ciò
può
risultare
comunque
utile per
una più
dettagliata
indagine di
alterazioni
particolarmente
superficiali
e per un più
accurato
studio della
regione
retroareolare
specialmente
in presenza
di capezzoli
voluminosi.
L’esame
ecografico
deve essere
condotto con
paziente
supina con
il braccio
corrispondente
alla
mammella
indagata
flesso ed
abdotto, con
la mano
sopra la
testa.
Questa
posizione
consente un
appiattimento
della
ghiandola ed
una maggiore
immobilità
nel corso
dell’esame.
Nel corso
dell’esame
ecografico
devono
essere
sistematicamente
ed
accuratamente
indagate
tutte le
porzioni
della
ghiandola
eseguendo
uno studio
prima per
quadranti e
poi in senso
radiale
consentendo
queste
seconde
scanzioni di
analizzare
più
correttamente
le strutture
del lobo
ghiandolare
nella sua
complessità
epiteliale e
connettivale
e l’asse del
dotto che
converge
verso il
capezzolo
(Teboul
1988).
L’esame
ecografico
della
mammella va
quindi
completato
da un
accurato
studio di
eventuali
alterazioni
linfonodali
in sede
ascellare ed
a livello
della
mammaria
interna.
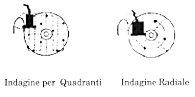
CRITERI
DIAGNOSTICI
ECOGRAFICI DELLE
ALTERAZIONI
FOCALI DELLA
MAMMELLA
La SIEOG
sulla base
dei dati
della
Letteratura
Internazionale
(Kobayashi
1974, Baum
1977, Kasumi
1982, Kasumi
1991, Leucht
1989) e
dell’esperienza
del proprio
Gruppo di
Studio
sull’Ecografia
della
mammella
(Gentili
1993)
ritiene
opportuno
che le
alterazioni
focali della
mammella
debbano
essere
sistematicamente
indagate
sulla base
dei seguenti
aspetti
dell’immagine
ecografica:
a)Forma-
viene
definita
regolare
quando la
formazione
presenta un
aspetto
rotondeggiante
e
grossolanamente
ovoidale
come nei
noduli
benigni. I
noduli
maligni sono
invece per
lo più
caratterizzati
da un
aspetto non
geometrico
con contorni
angolati e
spiculati
dovuti ai
processi
invasivi
rispetto al
parenchima
ghiandolare
contiguo. b)
Contorno-
indica allo
stesso tempo
sia le
caratteristiche
morfologiche
del contorno
del nodulo
che può
essere sia
liscio che
frastagliato
che la
possibilità
di una
corretta
definizione
del bordo
perimetrale
del nodulo
che può
essere netto
o sfumato.
c) Alone
Iperecogeno-
indica la
presenza a
ridosso del
confine del
nodulo di
una corona
di fine
iperecogenicità
che sfuma
nel tessuto
ghiandolare
contiguo.
Tale
fenomeno è
secondario
alla
presenza di
processi
microspiculari
che si
comportano
come
microcentri
di
diffusione
rifrangendo
le onde del
fascio
ultrasonico.
d) Echi
interni le
formazioni
cistiche
risultano
transoniche
o debolmente
ipoecogene
in caso di
contenuto
fluido
denso. I
noduli
solidi
benigni sono
caratterizzati
da echi fini
ed omogenei,
potendosi,
peraltro,
talora
osservare in
età avanzata
nel contesto
di
fibroadenomi
piccoli
focolai
iperecogeni
privi di
cono d’ombra
posteriore
dovuti a
zone di
involuzione
fibroialina
o grossolane
calcificazioni
nettamente
ecoattenuanti.
Nei
carcinomi si
rileva una
marcata
ipoecogenicità
di fondo nel
contesto
della quale
si possono
rilevare
echi
irregolari e
disomogenei
e lacune
ipoecogene
dovute a
zone
necrotico-colliquative.
e) Echi
posteriori-
l’ecogenicità
a livello
del tessuto
mammario
posteriore
al nodulo e
la
possibilità
di una
corretta
definizione
della parete
posteriore
del nodulo
stesso
dipende dal
quadro di
attenuazione
esercitato
sul fascio
ultrasonico
dalla
formazione.
È possibile
che vi sia
una
estinzione
dell’onda
con
formazione
di un cono
d’ombra
posteriore
in presenza
di
formazioni
nodulari
maligne ad
elevato
contenuto di
tessuto
fibroso
(scirro). In
tali casi
non risulta
definibile
la parete
posteriore
del nodulo
né
rilevabile
l’ecostruttura
del tessuto
ghiandolare
posto
inferiormente
al nodulo.
Si rileva
invece un
rafforzamento
degli echi
posteriormente
alla
formazione
in presenza
di strutture
meno
attenuanti
del normale
tessuto
ghiandolare
(cisti e
noduli
solidi
benigni ad
elevata ed
omogenea
componente
cellulare).
È inoltre
possibile
che gli echi
posteriori
alla
formazione
non
subiscano
significative
variazioni
rispetto ai
tessuti
circostanti
come avviene
nei
fibroadenomi.
f) Coni
d’ombra
bilaterali-
sono
rappresentati
da sottili
aree di
attenuazione
del fascio
ultrasonico
generantesi
a livello
delle
estremità
laterali di
formazioni
rotondeggianti.
Frequentemente
presenti
nelle
formazioni
benigne
(cisti,
fibroadenomi)
rappresentano
una
ulteriore
riprova del
contorno
netto e
liscio del
nodulo.
Risultano
invece
assenti nei
noduli
maligni ove
si possono
eventualmente
rilevare
solo coni
d’ombra
unilaterali
più
irregolari e
di maggiore
intensità.
g) Rapporto
L/T- indica
il rapporto
tra il
diametro
longitudinale
(L) e
trasverso
(T) del
nodulo.
Qualora
prevalga il
diametro
longitudinale
(L/T>1) vi è
il sospetto
di un
processo
maligno,
mentre
qualora
prevalga il
diametro
trasverso
(L/T<0.5) è
più
presumibile
che il
nodulo sia
benigno.
h)Effetto
della
compressione
sulla forma
e sugli echi
interni-
l’utilizzazione
di
apparecchiatura
in tempo
reale
permette di
evidenziare
l’effetto
della
compressione
esercitata
con la sonda
sul nodulo
rilevando
variazioni
della forma
e
dell’ecogenicità
interna. Il
rilievo di
distorsione
della forma
e di un
incremento
dell’omogeneità
degli echi
interni è
suggestivo
per una
natura
benigna.
Lo studio
dei suddetti
aspetti
ecografici
del nodulo
mammario va
completato
dalla
valutazione
di eventuali
alterazioni
del tessuto
mammario
contiguo al
nodulo
(tessuto
adiposo
preghiandolare,
creste del
Duret, dotti
galattofori).
PATOLOGIA
BENIGNA DELLA
MAMMELLA
I
caratteri
ecografici
del nodulo
benigno
della
mammella
sono
riportati
successivamente.

L’aspetto
ecografico
della cisti
semplice è
quanto mai
caratteristico
e
rappresentato
da una
formazione
anecogena
ovoidale
talora a
contorni
policiclici
a margini
netti con
rinforzo di
parete
posteriore e
coni d’ombra
bilaterali.

Il contenuto
della cisti
può
risultare
più o meno
ipoecogeno
per la
presenza di
versamenti
emorragici o
di liquido
denso
corpuscolato.
Nelle cisti
infette
oltre alla
presenza di
echi in
sospensione
o di
sedimento si
rileva un
ispessimento
iperecogeno
della parete
che si
continua con
un alone
ipoecogeno
costituito
dal tessuto
ghiandolare
contiguo
edemigeno.
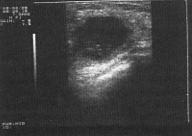
La presenza
di cisti
“sporche”
qualora non
si associ
una evidente
sintomatologia
flogistica
ed ancor più
il rilievo
di aggetti
iperecogeni
con
atteggiamento
vegetante
nel lume
cistico
necessitano
di una
tipizzazione
citologica
agobioptica
per il
rischio di
una
alterazione
maligna.
L’aspetto
ecografico
del
fibroadenoma
è
rappresentato
da una
formazione
ipoecogena a
contorni
regolari e
margini ben
delimitabili
non
ecoattenuante,
frequentemente
con coni
d’ombra
bilaterali,
caratterizzato
da un
rapporto L/
T inferiore
a 0.5.

L’ecogenicità
del nodulo
può comunque
variare a
seconda
della
diversa
rappresentazione
della
componente
epiteliale e
fibroconnettivale,
nonché per
la eventuale
presenza di
precipitati
fibrojalini
e calcifici.
Il
fibrolipoma
si presenta
ecograficamente
come una
formazione a
contorni ben
delimitabili
localizzata
superficialmente
nel contesto
del tessuto
adiposo
preghiandolare,
ecostrutturalmente
costituita
da un
tessuto
ipoecogeno
con fini
striature
ecogene ad
andamento
pressoché
parallelo al
piano
contenuto.
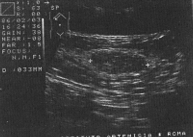
Tale aspetto
ecostrutturale
è simile a
quello delle
zolle
adipose
preghiandolari
delimitate
dai
ligamenti
del Cooper
che non
presentano
peraltro una
netta
delimitazione
dei contorni
su tutti i
piani di
scansione.
La patologia
flogistica
della
mammella,
facilmente
diagnosticabile
per
l’associarsi
del quadro
clinico
sintomatologico
di
arrossamento
cutaneo,
tumefazione
e dolore, è
rappresentato
ecograficamente
dalla
presenza di
ampie aree
di tessuto
ghiandolare
a contorni
non ben
delimitabili
disomogeneamente
ipoecogene
per i
fenomeni
edemigeno-congestizi.
In caso di
ascessualizzazione
in tale
contesto si
rilevano
focolai ad
ecostruttura
più
marcatamente
e
disomogeneamente
ipoecogena
riferibili
al materiale
fluido
-denso-necrotico-purulento
sovente
delimitati
da una
parete
iperecogena
a contorni
sfumati.
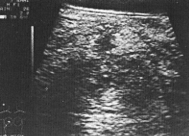
L’ectasia
dei dotti
galattofori
è
caratterizzata
da una
dilatazione
al di sopra
dei 2 mm di
tali
strutture
che possono
assumere un
andamento
serpiginoso.
Di
fondamentale
importanza
risulta lo
studio con
sonda ad
elevata
frequenza
del
contenuto e
delle pareti
di tali
dotti al
fine di
evidenziare
l’eventuale
presenza di
irregolarità
delle pareti
o di
formazioni
solide
papillomatose
aggettantesi
nel lume del
dotto.
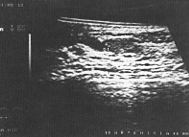
PATOLOGIA
MALIGNA DELLA
MAMMELLA
I
caratteri
ecografici
del nodulo
maligno sono
riportati
succesivamente.

L’aspetto
ecografico
basilare è
quello di
un’area
nettamente
ipoecogena
rispetto al
tessuto
ghiandolare
circostante
di forma
irregolare,
a contorni
frastagliati
ed a margini
mal
delimitabili.

Il
processo
invasivo
microspiculare
si può
manifestare
sotto forma
di una
corona
ecogena
ovvero di
un’area
iperecogena
spessa
alcuni
millimetri
situata sul
margine
prossimale
della
formazione.

I noduli
maligni
della
mammella
esercitano
frequentemente
una
attenuazione
della
trasmissione
del fascio
ultrasonico.
Tale
attenuazione
può essere
di entità
variabile
fino al
prodursi di
un cono
d’ombra
posteriormente
al nodulo
che
impedisce la
definizione
della parete
posteriore
del nodulo e
del tessuto
ghiandolare
retrostante.

Il cono
d’ombra
maligno è a
limiti
irregolari
centrale o
unilaterale
e quindi
differenziabile
dai coni
d’ombra
benigni di
parete o
prodotti da
calcificazioni.
II quadro di
attenuazione
dipende
dalla
presenza del
tessuto
fibroconnettivale
nel contesto
del nodulo
(Kobayaschi
1979): i
carcinomi
duttali di
tipo
scirroso e
lobulari
infiltranti
che
presentano
circa un 70%
di contenuto
fibroconnettivale
danno luogo
molto
frequentemente
ad un
evidente
cono d’ombra
posteriore
che risulta
invece
assente nei
carcinomi
midollari e
colloidei
che
presentano
un 20% di
tessuto
fibroconnettivale.
Il carcinoma
della
mammella
tende spesso
a presentare
ecograficamente
una
estensione
più sul
diametro
longitudinale
che
trasversale,
avendosi un
rapporto L/T
superiore ad
1. Esso
risulta
inoltre
negativo al
test della
compressione
non
rilevandosi,
in tale
condizione,
significative
deformazioni
della forma
del nodulo
né
sostanziali
variazioni
dell’ecostruttura
interna.
L’indagine
ecografica è
inoltre in
grado di
evidenziare
alterazioni
dei tessuti
ghiandolari
contigui al
nodulo
maligno.
Quando il
piano
cutaneo
della
mammella è
invaso dal
processo
neoplastico,
appare
ispessito,
potendosi
rilevare una
perdita di
regolarità
del profilo
convesso
mammario.
Il tessuto
adiposo
sottocutaneo,
presente
superiormente
al
carcinoma,
può
risultare di
spessore
nettamente
ridotto e
talora
punteggiato
da una fine
iperecogenicità.
Le travate
fibroconnettivali
di sostegno,
normalmente
disposte con
un andamento
pressoché
parallelo al
piano
costale,
risultano
sovvertite e
talora
mossate a
livello
della
neoplasia,
potendosi
rilevare
anche
alterazioni
delle creste
del Duret e
dei
ligamenti
del Cooper.
Si deve
tener
presente
come dei
tipi di
carcinomi ed
in
particolare
i carcinomi
midollare e
colloide
tendono a
non
mostrare,
all’indagine
ecografica,
evidenti
segni di
malignità
presentandosi
come
formazioni
di aspetto
simil
cistico a
contorni ben
delimitabili,
a contenuto
finemente
ipoecogeno e
non
ecoattenuanti.
La diagnosi
ecografica
risulta per
tali motivi
spesso
difficoltosa
e si basa
sul
completamento
diagnostico
agobioptico
sempre
necessario
in presenza
di
formazioni
pseudocistiche
in
particolare
qualora
riscontrate
in donne in
postmenopausa.
L’INDAGINE
ECOGRAFICA NELLA
DIAGNOSTICA
SENOLOGICA
Donne
sintomatiche
Nelle donne
che accusano
alterazioni
sintomatologiche
alle
mammelle
(mastodinia,
presenza di
tumefazioni
nodulari o a
placca) o
nelle quali
alla visita
clinica si
sia rilevata
una
tumefazione
mammaria,
l’iter
diagnostico
dipende
dall’età
della
paziente
(Feig 1992).
Nelle donne
molto
giovani, di
età
inferiore a
30 anni,
nelle quali
è
frequentemente
riscontrabile
un seno
denso a
prevalente
componente
ghiandolare,
l’ecografia
deve essere
considerata
l’esame
strumentale
di prima
istanza a
completamento
della visita
clinica.
L’ecografia
può essere
infatti in
questi casi
quasi sempre
già
dirimente e
conclusiva
consentendo
di
identificare
nella
maggior
parte dei
casi
alterazioni
benigne
della
mammella che
verranno
successivamente
sottoposte a
periodici
controlli
clinico
strumentali.
Nei casi
ecograficamente
dubbi si
procederà ad
un
approfondimento
diagnostico
Rx
mammografico
o
direttamente
ad una
tipizzazione
citologica
agobioptica
a seconda
delle
caratteristiche
della
mammella ed
in
particolare
al grado di
densità
della stessa
che possa o
meno rendere
difficoltosa
l’indagine
radiologica.
Nei casi di
mammella
secernente
secrezione
ematica o
sieroematica
si rende
comunque
necessario
l’impiego
della
mammografia
e
galattografia.
Nelle donne
tra i 30 ed
i 40 anni in
presenza di
mastodinia o
di
tumefazioni
a placca
l’ecografia
si può
ancora
considerare
l’esame di
prima
istanza a
seguito
della visita
clinica
necessitando
comunque,
qualora il
reperto
ecografico
sia di
alterazione
benigna, di
periodici
controlli
ecografici
ed Rx
mammografici
nel follow
up della
paziente.
In presenza,
alla visita
clinica, di
una
tumefazione
nodulare
circoscritta
l’ecografia
è in grado
di
differenziare
la natura
cistica o
solida della
stessa
risultando
comunque
sempre
opportuna
una
integrazione
diagnostica
Rx
mammografica
in tutti i
noduli
solidi anche
se
ecograficamente
non
sospetti.
Tutti i casi
dubbi o
sospetti su
base
ecografica
e/o
mammografica
richiedono
comunque un
accertamento
bioptico
citologico.
Oltre i 40
anni ed
ancor più in
età
post-menopausale
la
mammografia
rappresenta
l’esame di
prima
istanza
nella
paziente
sintomatica,
potendo
comunque
l’ecografia
rappresentare
un valido
completamento
diagnostico
nella
differenziazione
solido/liquido
della
formazione,
nello studio
delle
mammelle ad
elevata
componente
fibroghiandolare
e nello
studio di
quelle
opacità
nodulari che
all’indagine
mammografica
non
presentino
tutti gli
aspetti
semeiologici
di
benignità.
Ovviamente
ed ancor più
in questa
fascia di
età che è a
più elevato
rischio per
carcinoma
della
mammella,
tutti i casi
dubbi o
sospetti
necessitano
di un
approfondimento
diagnostico
citologico
agobioptico.
Donne
asintomatiche:
screening e
diagnosi precoce
L’unico
screening
diagnostico
in donne
asintomatiche
che si è
dimostrato
in grado di
ridurre la
mortalità
per
carcinoma
della
mammella è
l’esame
mammografico
eseguito a
cadenza
biennale
nelle donne
con età
superiore ai
50 anni. Al
di sotto di
tale età non
si hanno
attualmente
metodiche di
indagine di
screening di
efficacia
dimostrata,
risultando
tuttora una
questione
“aperta” il
problema
dello
screening
nelle donne
tra i 40-49
anni (M.
Rosselli Del
Turco 1994).
Piuttosto
che di un
discorso di
screening
nella donna
asintomatica
di età
inferiore a
50 anni si
può proporre
un
auspicabile
tentativo di
diagnosi
precoce del
cancro della
mammella in
gruppi di
popolazione
ad alto
rischio.
L’identificazione
di quali
debbano
essere le
categorie di
popolazione
a rischio da
indagare, i
protocolli
di indagine
strumentale
da attenuare
e
l’efficacia
di una
diagnosi
precoce del
tumore della
mammella in
donne
asintomatiche
di età
inferiore ai
50 anni sono
peraltro
tuttora
oggetto di
studio e di
ricerca.
BIBLIOGRAFIA
ASPETTI
ECOGRAFICI
DEL NODULO
BENIGNO
| Forma |
Regolare |
| Contorno |
Netto liscio |
| Alone iperecogeno |
Assente |
| Echi interni |
Fini ed omogenei |
| Echi posteriori |
Aumentati |
| Coni d’ombra bilaterali |
Presenti |
| Rapporto L/T |
< 0,5 |
| Test compressione |
Positivo |
Assenza
di
alterazioni
del
tessuto
ghiandolare
contiguo
(tessuto
adiposo,
travate
fibroconnettivali)
ASPETTI
ECOGRAFICI
DEL NODULO
MALIGNO
| Forma |
Irregolare |
| Contorno |
Sfumato e liscio
Sfumato e frastagliato |
| Alone iperecogeno |
Presente |
| Echi interni |
Marcata ipoecogenicità
Ipoecogenicità con echi grossolani |
| Echi posteriori |
Cono d’ombra centrale
Cono d’ombra unilaterale |
| Rapporto L/T |
> 1 |
| Test compressione |
Negativo |
Alterazione
del
tessuto
ghiandolare
contiguo
(tessuto
adiposo,
travate
fibroconnettivali,
dotti
galattofori)